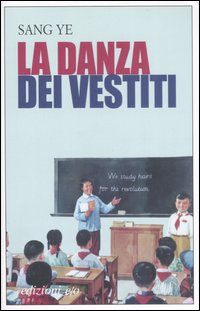 Continuando il viaggio in Cina iniziato con "La buona terra", ho deciso di leggere un curioso volumetto scovato qualche tempo fa tra i miei amati scaffali di libri usati. L'autore è Sang Ye, scrittore e giornalista di nazionalità cinese che dal 1989 vive in Australia, a Brisbane, e da lì continua a raccontare la sua terra d'origine. Lo stile di questo autore è particolare: si distingue infatti per essere un collezionista di storie; i suoi racconti non sono inventati né frutto dell'esperienza personale, quanto una riscrittura quasi parola per parola di interviste fatte a persone qualsiasi, incontrate per strada. Sang Ye riprende questo materiale, lo organizza in una sorta di monologo, cercando di mantenere lo stile del narratore, e poi lo pubblica su giornali, in saggi o raccolte. Questo è il suo modo di raccontare la Cina attraverso la voce non di un solo intellettuale o di una persona dalla vita speciale, ma dal punto di vista di centinaia di cinesi qualunque, persone diversissime con idee anche contrastanti tra loro, ma che insieme concorrono a creare un mosaico variegato il più vicino possibile alla realtà del Paese.
Continuando il viaggio in Cina iniziato con "La buona terra", ho deciso di leggere un curioso volumetto scovato qualche tempo fa tra i miei amati scaffali di libri usati. L'autore è Sang Ye, scrittore e giornalista di nazionalità cinese che dal 1989 vive in Australia, a Brisbane, e da lì continua a raccontare la sua terra d'origine. Lo stile di questo autore è particolare: si distingue infatti per essere un collezionista di storie; i suoi racconti non sono inventati né frutto dell'esperienza personale, quanto una riscrittura quasi parola per parola di interviste fatte a persone qualsiasi, incontrate per strada. Sang Ye riprende questo materiale, lo organizza in una sorta di monologo, cercando di mantenere lo stile del narratore, e poi lo pubblica su giornali, in saggi o raccolte. Questo è il suo modo di raccontare la Cina attraverso la voce non di un solo intellettuale o di una persona dalla vita speciale, ma dal punto di vista di centinaia di cinesi qualunque, persone diversissime con idee anche contrastanti tra loro, ma che insieme concorrono a creare un mosaico variegato il più vicino possibile alla realtà del Paese.La raccolta "La danza dei vestiti" prende il nome dalla tematica che lega la maggior parte dei racconti: tutti partono da un oggetto, di solito un capo di vestiario, a cui si lega un ricordo, un'esperienza. La persona che lo possedeva (e che poi l'ha ceduto o venduto a Sang Ye, che di questi oggetti fa collezione) narra un episodio della propria vita, il periodo storico a cui fa riferimento, descrive la collocazione geografica e la situazione sociale che ne ha fatto da sfondo, e spiega al lettore perché quell'oggetto è stato conservato per anni, a volte gelosamente, cosa esso rappresentava, che importanza ha giocato nella sua vita.
Per me che ho l'anima del collector, cioè di chi non butterebbe via mai nulla nella folle convinzione che tutto possa tornare utile o essere riutilizzato, io che investo emotivamente anche nei biglietti del treno e nei pass del campeggio, dicevo, per me questo argomento è seducente. Il pensiero che un uomo possa tenere per 40 anni un sigillo, una camiciola o un telefono non mi sorprende affatto; anzi, mi scalda il cuore. Quindi questo libricino mi ha conquistato quasi subito.
Nonostante sia stato pubblicato nella traduzione italiana soltanto nel 2007, le interviste che compongono "La danza dei vestiti" risalgono agli anni '90. Insomma, sono un po' passatelle... Ma tutti i ricordi si riferiscono a parecchi anni prima, tra la Liberazione, cioè quando i comunisti prendono il potere nel 1949, e la fine della Rivoluzione Culturale, quel movimento voluto da Mao che affossò per una decina di anni il mondo culturale cinese, tra il 1967 e il 1976 circa.
Ohibò, direte ora voi, quali incredibili conoscenze di storia possiede codesta donna! E io invece non ne so nulla, la storia della Cina non l'abbiamo mai studiata a scuola, e poi agli anni '60 manco ci siamo arrivati in quinta superiore... Come potrò mai io comprendere tale libro?
Ecco, ci tengo a chiarire questo punto: io di storia cinese non so una mazza di niente, o meglio, inizio a imparare qualcosa leggendo questi libri. Invece devo ringraziare le edizioni e/o e nella fattispecie Maria Gottardo e Monica Morzenti, vale a dire le traduttrici di questo libro, per avere aggiunto un'introduzione esplicativa del periodo storico in questione e di chi fossero i personaggi politici citati più volte nei racconti. Senza il loro aiuto non ne sarei mai venuta a capo...
Non essendo un romanzo è un po' difficile trovare un modo per parlare di questo libro. Ogni narratore fa un po' a sé, quasi come in un reportage, e ognuno ha una vita slegata dalle altre da raccontare. Ciò che posso dire è cosa mi ha colpito maggiormente.
La prima cosa che mi viene in mente è l'amarezza per la vita degli intellettuali in Cina durante il periodo della rivoluzione. Proprio per la loro cultura, la loro apertura al mondo, questi furono percepiti come persone "reazionarie", che in qualche modo si credevano superiori e per questo avrebbero osteggiato la rivoluzione comunista. Che questo sia stato una realtà o meno (è innegabile che gruppi di intellettuali si opposero ai piani di Mao, ma forse anche con cognizione di causa...), il trattamento che queste persone subirono fu doloroso: buttati fuori da laboratori, scuole e uffici in cui lavoravano, furono mandati nei campi a lavorare come contadini, svolgendo i lavori più umili in condizioni igieniche precarie e vivendo in povertà assoluta, così da "rieducarli". Si crearono persino campi di lavoro appositi, chiamate "Scuola 7 maggio", dove i funzionari dovevano essere riportati sulla retta via. Pare, dalle testimonianze raccolte, che questi non fossero altro che luoghi di sopraffazione giornaliera, dove operai in forza alle fila del partito che avevano ricevuto torti (almeno a loro parere...) da parte dei funzionari o che semplicemente negli anni si erano sentiti svantaggiati, in posizione subordinata a causa della mancata istruzione o altro, si vendicavano sui malcapitati arrivando persino alle torture. Di tutto ciò non si parla davvero nel racconto che li cita ("102 biglietti ferroviari"), ma si percepisce il dolore di aver subito un'ingiustizia che ha stravolto loro l'esistenza.
Mi ha fatto tanto pensare, perché l'unica colpa che avevano la maggior parte di queste persone era di amare lo studio e di aver potuto, chi grazie alla famiglia benestante e chi con tanti sacrifici, ottenere un titolo e di conseguenza perseguire una carriera. Io, un'insegnante di liceo, per di più di lingua straniera, sarei stata presa di mira quasi sicuramente. E al giorno d'oggi, in un mondo che svaluta sempre più il valore del titolo di studio parificando e appianando le differenze di preparazione, arrivando a negare persino il valore della scienza in virtù di complotti e scuole di vita vera, rivedo quell'odio figlio dell'invidia, dell'ignoranza, e un po' mi fa paura. Perché ad un certo punto persino Mao si accorse che senza intellettuali il Paese si sarebbe arenato inevitabilmente.
Un'altra categoria di perseguitati che mi ha impietosito molto sono i borghesi presenti in Cina durante la rivoluzione comunista. Che colpa ha una ragazzina a malapena adolescente di essere nata in una famiglia mediamente agiata? Che male ha fatto al Paese, ai suoi connazionali e al popolo? Dove sta la volontà personale? Di tutto ciò non si parla mai perché al popolo inferocito la verità e la giustizia non interessano. Ciò che conta è far scorrere il sangue, che qualcuno paghi, che stia male quanto pensiamo di aver sofferto noi.
In "Sarà un boccone amaro anche in una vita futura" una donna racconta dell'espropriazione subita dalla propria famiglia. Accadde nel 1966, lei aveva 15 anni e con lei fu preso di mira il padre. A compiere il dovere di requisire i beni della famiglia fu la "Squadra delle Guardie Rosse maoiste", che altro non erano che un gruppo di ragazzine adolescenti guidate da una donna analfabeta e meschina. I borghesi venivano espropriati dall'oggi al domani, attraverso un'azione di polizia: interrogati, picchiati selvaggiamente e poi arrestati o, nella migliore delle ipotesi, abbandonati a se stessi, senza un soldo né un vestito né un tetto a cui far ritorno. La donna racconta che all'epoca lei e il padre si nascosero nel magazzino della casa, che era sì stato sigillato, ma che era anche il posto più umile e malridotto. Lì nel giro di meno di un anno il padre trovò la morte, prostrato da una malattia cardiovascolare che non poteva più tenere sotto controllo, perché ai borghesi non era permesso essere curati negli ospedali né ricevere medicinali. La donna ricorda anche questo dolore, la disperazione con cui cercò di salvare suo padre senza riuscirci, la sofferenza di sentirlo spirare tra le proprie braccia dopo l'ennesimo scorno della responsabile del partito, che negava persino che la sua fosse vera malattia.
La donna dovette poi andare a lavorare in fabbrica per otto anni, in modo da rieducarsi e diventare una brava comunista, vivendo da sola in condizioni inumane e percorrendo ogni giorno a piedi 30 chilometri per raggiungere il posto di lavoro. Tutto ciò è raccontato con reale dolore, ma non solo: la rabbia, l'astio, la sete di vendetta della narratrice è tanta, perché come ripete più volte per questi delitti non ha mai pagato nessuno e lei non può perdonare.
Non è l'unica a ritornare su questo punto, quello delle crudeltà e delle morti causate dalle decisioni del partito per cui nessuno è mai stato processato, accusato, tanto meno condannato. Altri racconti parlano di persone uccise per capriccio, quasi, risorse immense sprecate per far bella figura o accontentare un rappresentante politico di alto livello che, nella sua ignoranza, chiedeva di fare imprese impossibili o altamente dispendiose e inutili. E' questa una delle ombre che pesa su molte delle storie, un senso di inconcluso, anche a distanza di decenni dai fatti, come se non si fosse mai messa la parola fine su ciò che è stato perché le autorità non ne hanno mai voluto prendere coscienza e ammettere di aver sbagliato. E' un'eredità pesante da portare che, come tutte le ferite non sanate, nel tempo creerà una voragine interna al Paese nutrita di rancore e diffidenza di cui già oggi vediamo alcune conseguenze.
Una cosa che mi ha colpito positivamente, invece, è la forza di carattere che mostrano alcuni dei narratori, un coraggio di dire la propria opinione senza troppi giri di parole, anzi utilizzando un'ironia tagliente e davvero accattivante. La critica che si percepisce nei confronti degli eventi dei decenni dal '50 alla fine degli anni '70 è forte e quasi affatto celata. Consiglio la lettura del racconto "Il vestito dell'imperatrice" per averne un assaggio lampante.
Infine il tema forse principale della raccolta: quello dell'abbigliamento, appunto. Io ho un rapporto non felicissimo con la moda, l'apparenza e i dettami nell'abbigliamento. Anzi, direi che sono proprio insofferente alle imposizioni di uniformi e vestiti standardizzati, perché a me quello che decidono gli altri di solito fa abbastanza schifo e mi sta pure male. Odio il concetto di fashion, di adattarsi a ciò che qualcun altro ha deciso essere trendy e odio spendere soldi per vestiti che manco mi piacciono. Soprattutto odio il concetto di bella presenza. Non so, sarà che come donna non rappresentativa della bellezza canonica e poco interessata all'apparenza ho sempre investito molto nel mio cervello e trascurato il guscio, esasperando perfino questa dicotomia. Oppure sarà che sono un po' strana io, però questa faccenda delle uniformi mi colpisce molto.
La rivoluzione di Mao non fu soltanto nelle teste, nell'organizzazione sociale, nella cultura: il deciso cambiamento nell'abbigliamento fu parte integrante dell'operazione di marketing politico. Il mondo cinese, che fino ad allora aveva vestito i propri panni tradizionali, si uniformò in un unico mondo di blu, verde e grigio, i colori delle tute tipiche del partito comunista. Conformismo, sempre, a ogni costo, l'annullamento della libertà individuale sottolineato dalla soppressione di qualsiasi espressione estetica personale.
Tuttavia, proprio perché in verità in Cina si susseguirono movimenti, leader diversi, alleanze, altrettanto rapidamente cambiava la moda. Non nelle grandi cose, ma nei dettagli: un colletto alla Mao piuttosto che alla Lenin, un vestito tradizionale da donna come il qipao messo al bando per imitare lo stile della first lady Jiang Qing e poi riportato in auge. Tutto ciò mentre la gente in Cina stentava a mangiare tutti i giorni e le possibilità di comprare vestiti nuovi era alquanto remota.
Non mi ero mai fermata molto a pensare quanto anche l'abbigliamento, quando è imposto, sia un modo per controllare le persone. Sinceramente leggerne il racconto dalle labbra di chi ha vissuto quel periodo non ha fatto altro che inasprire il mio rifiuto per quel genere di uniformità. E mi commuove un po' il pensiero che qualcuno abbia conservato con amore, per tanti anni, una camicia pur sapendo che non l'avrebbe mai più indossata, solo perché era un ultimo frammento di un mondo antico che rapidamente spariva per non ritornare più. La Cina di oggi non ha più niente a che fare con quella di inizio '900.
Insomma, "La danza dei vestiti" non è un libro che cambia la vita, che faccia gridare al genio o a premi internazionali, ma è uno scorcio inusuale sul periodo maoista cinese e lo stile particolare dell'autore lo rende agile, ricco, vario e mai noioso. Io lo consiglio sicuramente a chi voglia leggere qualcosa sulla Cina del secolo appena trascorso da un punto di vista alternativo e scritto in maniera semplice e sintetica.
Nessun commento:
Posta un commento